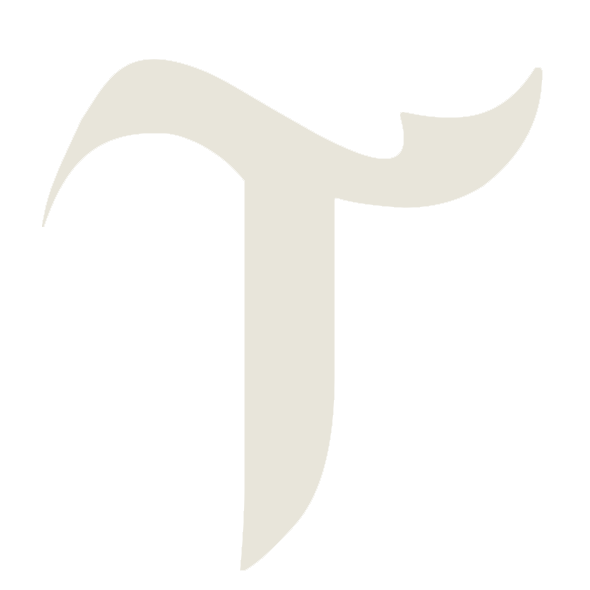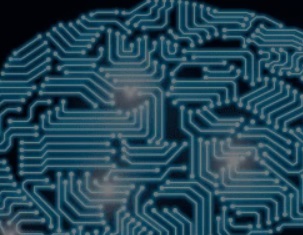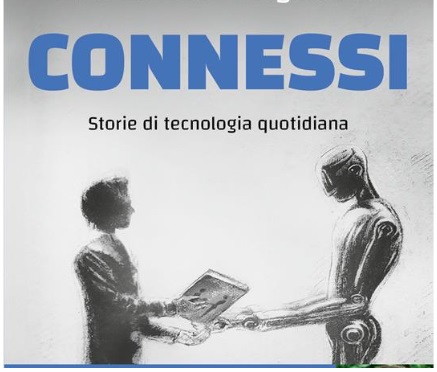Dalla scrittura alla vendita, l’IA cambia il mercato del lavoro. E l’UE risponde con l’AI Act per tutelare cittadini e imprese
La diffusione dell’intelligenza artificiale (IA), soprattutto nelle sue forme generative come ChatGPT o Copilot, sta riplasmando il mondo del lavoro. Compiti come scrivere testi, analizzare dati o assistere clienti sono oggi eseguibili da software, spesso con una velocità ed efficienza superiori a quelle umane. Ma mentre molte aziende, come Amazon o IBM, adottano l’IA per aumentare la produttività e tagliare i costi, si accende il dibattito sugli impatti occupazionali e normativi.
Secondo il Work Trend Index 2024 di Microsoft e LinkedIn, i ruoli più a rischio sono quelli legati alla comunicazione, alla produzione di contenuti e all’amministrazione: traduttori, venditori, assistenti clienti, scrittori. L’analisi si basa su oltre 200.000 interazioni con Copilot e conferma che le professioni che richiedono competenze cognitive e linguistiche sono particolarmente vulnerabili all’automazione generativa.
Anche l’AI Index 2024 della Stanford University conferma il trend: le attività cognitive di routine – come redigere testi, classificare informazioni o rispondere a clienti – sono quelle dove l’IA ha già superato la performance umana media. Non sorprende quindi che IBM, nel 2023, abbia annunciato il congelamento di 7.800 posizioni amministrative ritenute automatizzabili nei cinque anni successivi (Bloomberg).
Non basta una laurea
La trasformazione è così profonda che, oggi, nemmeno un titolo di studio universitario rappresenta una garanzia. Secondo l’OECD Skills Outlook 2025, molte professioni “intellettuali” – compresi insegnanti, economisti, storici – sono considerate ad alta esposizione all’IA, poiché le attività che svolgono possono essere replicate da algoritmi. Come afferma Erik Brynjolfsson dello Stanford Digital Economy Lab, “la sfida non è solo perdere il lavoro, ma perderlo perché non ci si è adattati abbastanza in fretta”.
L’AI Act e la risposta dell’Unione Europea
Proprio per affrontare le potenziali derive dell’automazione e garantire un’adozione responsabile dell’IA, l’Unione Europea ha approvato nel marzo 2024 l’Artificial Intelligence Act (AI Act), il primo regolamento globale sull’intelligenza artificiale.
L’AI Act, che entrerà in piena applicazione tra il 2025 e il 2026, classifica i sistemi di IA in quattro categorie di rischio: minimo, limitato, alto e inaccettabile. Le applicazioni ad alto rischio – come i sistemi usati per il reclutamento del personale, la valutazione scolastica o il punteggio di credito – saranno soggette a obblighi stringenti: trasparenza, tracciabilità, documentazione tecnica e supervisione umana.
Questo ha implicazioni dirette per il mondo del lavoro. Secondo la Commissione Europea, le aziende che utilizzano IA nei processi di selezione, valutazione delle performance o gestione del personale dovranno garantire il rispetto di diritti fondamentali, come la protezione dei dati, la non discriminazione e il diritto all’informazione.
Nel frattempo, l’Italia ha avviato l’istituzione del Comitato interministeriale per l’IA, che affiancherà l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel definire le linee guida nazionali. Tra le priorità: sostenere le PMI nell’adozione etica e sicura dell’IA, anche tramite il programma europeo Digital Europe.
I lavori più (e meno) colpiti
Secondo il Future of Jobs Report 2024 del World Economic Forum, entro il 2027 il 44% delle competenze lavorative subirà trasformazioni. A subire il maggior impatto saranno i lavori d’ufficio, l’amministrazione, le vendite e i contenuti digitali. Anche settori apparentemente stabili, come l’istruzione o la consulenza finanziaria, sono in fase di ridefinizione.
Tuttavia, alcune professioni mostrano maggiore resilienza: operatori tecnici, manutentori di impianti, personale sanitario, educatori della prima infanzia. La loro forza risiede nella componente pratica, empatica o relazionale, ancora difficilmente replicabile dall’IA.
Ma attenzione: “essere meno esposti non significa essere al sicuro”, ammonisce il report McKinsey 2025. Anche i mestieri tradizionali subiranno un’evoluzione, spinti dall’integrazione di tecnologie intelligenti nei contesti produttivi e logistici.
La formazione è la chiave
In questo scenario, il ruolo dell’istruzione è cruciale. Secondo un’indagine di Pearson (2024), la Gen Z sta privilegiando percorsi percepiti come “anti-IA”, come l’educazione, la psicologia o le scienze della salute. Tuttavia, anche questi ambiti dovranno confrontarsi con l’adozione di strumenti intelligenti, come tutor virtuali e software predittivi.
Serve dunque un ripensamento radicale dei programmi formativi. Le università e le scuole professionali devono puntare su competenze trasversali (soft skills), alfabetizzazione digitale, pensiero critico e capacità di lavorare in ambienti complessi. Non basta più saper usare la tecnologia: bisogna imparare a interrogarla, gestirla, integrarla.
Come sostiene il Digital Education Action Plan della Commissione Europea, occorre investire in educazione al pensiero computazionale, intelligenza artificiale e cybersecurity sin dalle scuole primarie, per preparare una generazione capace di convivere con la tecnologia in modo consapevole.
Verso un mercato ibrido
La vera posta in gioco non è la sostituzione dell’essere umano, ma la sua integrazione con l’intelligenza artificiale. Le aziende che sapranno valorizzare questa alleanza avranno un vantaggio competitivo nel lungo periodo. E i lavoratori che riusciranno ad aggiornarsi – imparando a usare gli strumenti di IA per aumentare produttività, creatività ed efficienza – saranno i più richiesti.
In questo senso, il futuro del lavoro non è determinato dalla tecnologia, ma dalle scelte umane che ne guideranno l’utilizzo. Come ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Europea: «L’intelligenza artificiale può essere una forza positiva, se regolata e controllata nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e dell’innovazione europea».