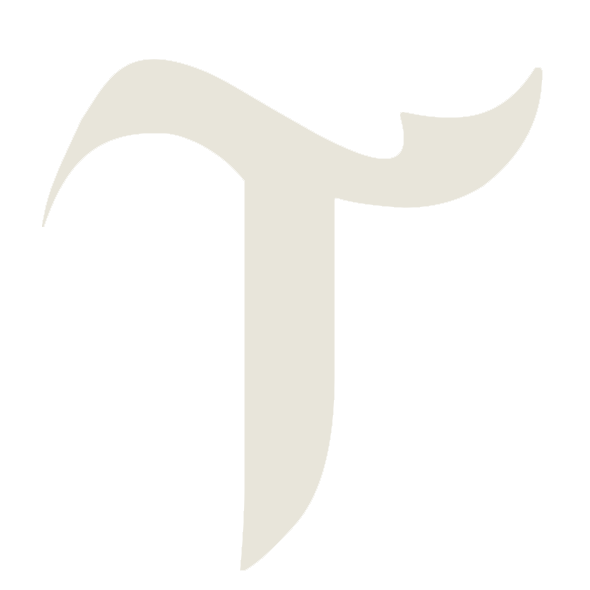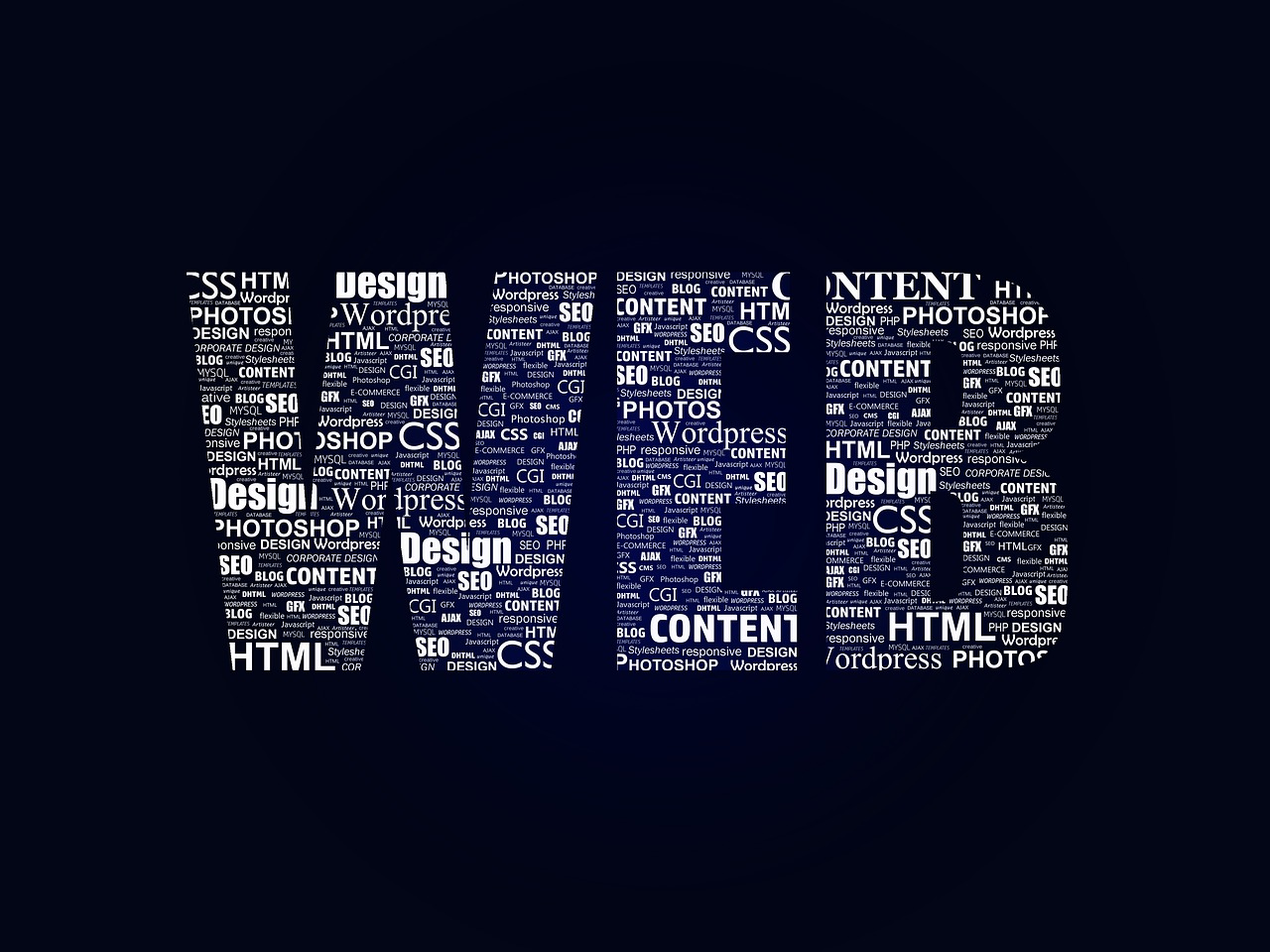Ospitalità di giovani “au pair”
Una fotografia del fenomeno, tra prassi diffuse e la necessità di un quadro giuridico chiaro e uniforme a livello europeo
L’ospitalità di giovani “au pair” è una pratica consolidata in molte famiglie italiane, soprattutto in contesti urbani e borghesi, dove l’equilibrio tra lavoro e cura dei figli richiede forme flessibili di assistenza domestica. Ma al di là del contesto familiare, il fenomeno si inserisce in una più ampia cornice europea di mobilità giovanile e scambio culturale, spesso poco regolamentata e soggetta a interpretazioni divergenti.
Chi sono gli au pair?
Il termine francese au pair significa “alla pari” e rimanda a un principio di reciprocità: il giovane o la giovane ospite vive con una famiglia, offre un aiuto leggero in casa (soprattutto nella cura dei bambini, ma non necessariamente), e in cambio riceve vitto, alloggio e una piccola somma come “argent de poche”, per i più giovani configurata come “paghetta” settimanale. L’obiettivo principale non è il guadagno, bensì lo scambio culturale, l’apprendimento della lingua e l’esperienza all’estero.
L’Italia: uso comune, quadro incerto
In Italia, l’ospitalità di au pair non è regolata da una legge ad hoc. Il riferimento normativo è piuttosto generico e risale alla Convenzione europea del Consiglio d’Europa sul collocamento alla pari (Strasburgo, 1969), ratificata dall’Italia con la legge n. 304 del 1973. Questa normativa è oggi considerata datata e e forse non più adatta a disciplinare un fenomeno molto cambiato negli anni.
Nella prassi, le famiglie ospitano au pair per periodi che variano da pochi mesi fino a un anno, spesso attraverso agenzie specializzate o piattaforme online. I giovani provengono soprattutto da paesi dell’Unione europea, ma anche da America Latina, Ucraina, Georgia e Filippine. Ricevono in genere tra i 400 e i 500 euro al mese, con vitto e alloggio inclusi: somme maggiori possono corrispondere a impegni maggiori in famiglia. Non hanno un contratto di lavoro vero e proprio, ma nemmeno uno status giuridico chiaramente definito.
La normativa europea e le sue lacune
La Commissione europea, pur riconoscendo il valore interculturale del programma au pair, non ha ancora elaborato una direttiva vincolante che armonizzi le normative nazionali. Alcuni paesi (come la Germania, la Francia e i Paesi Bassi) hanno introdotto regolamenti dettagliati, definendo orari di lavoro (generalmente non più di 30 ore settimanali), livelli minimi di compenso, assicurazione sanitaria obbligatoria e accesso a corsi di lingua.
In Italia, queste tutele sono affidate alla contrattazione privata e alle indicazioni delle agenzie, con il rischio di scivolare facilmente nell’irregolarità: au pair che lavorano oltre le ore previste, famiglie che non garantiscono l’accesso a un’istruzione linguistica, situazioni di sfruttamento non sempre denunciabili. Importante è prendere accordi scritti e rispettarli con attenzione.
Un’opportunità da valorizzare (meglio)
Secondo i dati raccolti da AuPairWorld, una delle principali piattaforme europee del settore, ogni anno sono alcune migliaia le famiglie italiane che ospitano giovani au pair, anche se non esistono numeri ufficiali aggiornati. La pandemia ha temporaneamente ridotto il flusso, ma la ripresa post-Covid ha riportato in auge la formula, complice anche l’aumento dei costi per servizi di baby-sitting professionali.
L’esperienza au pair rimane un’occasione di crescita sia per i giovani che per le famiglie ospitanti. Ma richiede maggiore chiarezza normativa, soprattutto per evitare abusi e garantire diritti minimi. Alcune associazioni europee propongono l’introduzione di uno “statuto europeo dell’au pair”, con criteri comuni su orari, compensi, assicurazioni e standard minimi di qualità. Un passo necessario, anche alla luce del crescente intreccio tra mobilità giovanile e mercato del lavoro informale.