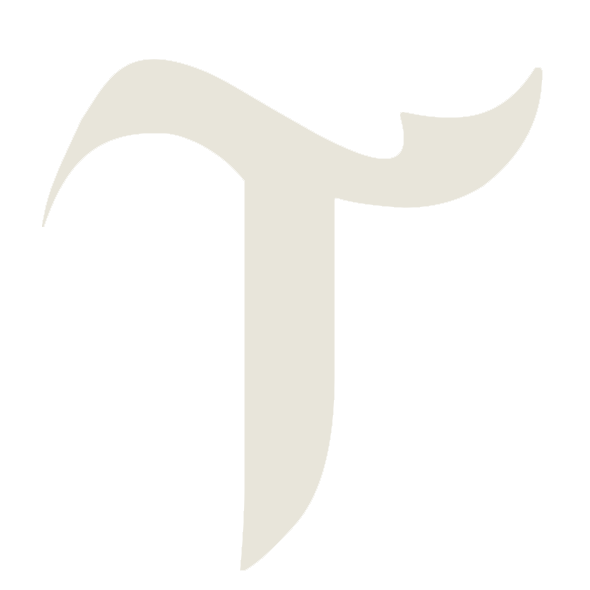Mentre la stampa inglese e americana esalta la novità, anche in Italia emerge un consenso tecnico-politico: convergono tutti verso il nodo centrale del nuovo approccio della BCE per rendere sostenibile la politica monetaria.
A fine luglio 2025, la Banca Centrale Europea ha annunciato una rivoluzione silenziosa ma profonda: l’introduzione di un fattore climatico all’interno del quadro di valutazione dei collaterali accettati nelle operazioni di rifinanziamento. Tale misura, operativa dalla seconda metà del 2026, mira a ridurre il valore attribuito agli attivi – in particolare obbligazioni corporate emesse da società non finanziarie – qualora siano esposte a rischi climatici legati alla transizione verde.
La copertura internazionale: Usa e Regno Unito
-
Reuters (USA/UK) sottolinea come la Fed americana abbia recentemente abbandonato un’iniziativa globale su rischio climatico, mettendo in risalto il contrasto con la BCE, che ha invece rilanciato il suo impegno inserendo considerazioni ambientali nella politica monetaria. Inoltre, Reuters avverte che alcune banche europee hanno già ricevuto multe per ritardi nella disclosure sui rischi climatici
-
Anche il Financial Times ha dedicato articoli di rilievo al tema, evidenziando come il prossimo shock finanziario globale potrebbe avere origine proprio dai rischi fisici del clima, con impatti sistemici sui mutui e sul mercato immobiliare, problemi già emergenti negli Usa
-
Nel Regno Unito, però, gli approfondimenti hanno riguardato soprattutto l’enfasi sui dossier ambientali delle grandi banche, meno sul lato collaterale.
Il confronto con l’Italia
In Italia, testate come Il Sole 24 Ore e altre nel mondo della finanza hanno riportato la notizia con toni più tecnici, ma comunque positivi, evidenziando che il Consiglio direttivo della BCE ha introdotto il fattore climatico come buffer per tutelare l’Eurosistema da shock legati alla transizione ambientale. La misura integra e corona le iniziative precedenti della BCE, già impegnata dal 2022 a introdurre limiti e obblighi informativi sulle garanzie legate a società ad alta impronta di carbonio.
In più, ANRA (l’Associazione nazionale dei risk manager) ha descritto l’inserimento del fattore climatico nel risk management come una svolta significativa, destinata a rafforzare la resilienza della politica monetaria e indirizzare gli operatori verso portafogli più sostenibili.
Punti di convergenza e differenze
| Aspetto | Comunità anglosassone | Italia |
|---|---|---|
| Contesto | Focus su contrapposizione con Fed e ruolo dei rischi fisici del clima (es. assicuzioni, immobili) | Attenzione alla coerenza con le politiche BCE preesistenti (deculturizzazione, divulgazione CSRD, limiti collaterali) |
| Focus editoriale | Il valore innovativo del meccanismo e la sua natura economica globale | Implicazioni tecniche, tempistiche, coinvolgimento normativo e adeguamento del comparto bancario |
| Prospettive | Preoccupazione per effetti sistemici globali, possibilità di spillover anche negli Usa | Visione operativa e di gestione del rischio contingente e graduale |
Come funziona il fattore climatico
Le banche generalmente stimano tre dimensioni all’origine del calo di valore:
-
Stressor settoriale, applicato uniformemente sulle obbligazioni del settore più a rischio, come evidenziato dallo stress test ambientale 2024 del patrimonio BCE.
-
Esposizione dell’emittente, basata sulla metodologia CSPP utilizzata dalla BCE stessa per valutare la transizione aziendale.
-
Sensibilità dell’attivo, ossia la sua vulnerabilità rispetto agli shock climatici inattesi.
Lo score risultante condurrà a un aggiustamento – un haircut addizionale – sul valore nominale dell’attivo collaterale.
Le controparti bancarie che presentano portafogli con alta esposizione climatica potrebbero vedere una riduzione significativa della liquidità ottenibile tramite collateral. Tuttavia, l’incentivo della BCE è quello di mantenere calibrazioni proporzionate, così da garantire una continuità operativa e una trasmissione fluida della politica monetaria.
Il quadro normativo europeo
Questa misura si inscrive in un percorso complesso, che parte dal Green Deal europeo, passa al SFDR, e raggiunge le più recenti evoluzioni normative come la CSRD e la Taxonomy UE, entrate in vigore tra il 2024 e il 2025. Le istituzioni finanziarie, soprattutto in Italia, sono oggi obbligate a integrare rischi climatici nei processi decisionali e informativi, coerentemente con l’evoluzione normativa europea.
Verso un futuro climatico-finanziario
L’introduzione del fattore climatico rappresenta per la BCE un cambio di paradigma: dalla semplice considerazione dei rischi alla loro valorizzazione operativa all’interno del cuore della politica monetaria. Come scrive la stampa USA e UK, questo meccanismo può disegnare un nuovo modello di central banking responsabile, integrato e sostenibile; in Italia però si guarda anche alla gradualità dell’attuazione e alla capacità delle controparti di adattarsi.
I prossimi passi: consultazioni e iter normativi nel corso del 2025, finalizzazione dei criteri e raccolta dati climatici fino al primo trimestre 2026, con la piena attuazione prevista entro la seconda metà del 2026. In sintesi, l’Europa prende l’iniziativa in modo concreto, mentre oltreoceano si registra un progressivo disimpegno. In Italia il tema è trattato con rigore tecnico ma crescente coinvolgimento politico: la finanza europea sembra ormai aver imboccato senza ritorno la strada della sostenibilità integrata nella gestione del rischio.